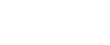MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
IL PONTE DELLA GHISOLFA, Giovanni Testori - a cura di G. Zanello
Giovanni Testori, IL PONTE DELLA GHISOLFA , Universale Feltrinelli, 2013, prima pubblicazione 1958
Che cos’è propriamente ll ponte della Ghisolfa? Un romanzo? Una raccolta di racconti? Né l’uno né l’altro. Unitaria è l’ambientazione, la zona di Milano allora al limitare dei campi, all’estremo nord- ovest, un territorio separato dalla città dall’intrico di binari risultante dall’incontro delle Ferrovie dello Stato con le Ferrovie Nord, ad essa collegato solo da un ponte, sorto in prossimità dell’antica Cascina Ghisolfa. Intorno al ponte prese a svilupparsi, tra le due guerre, un quartiere popolare, ingrandito nella seconda metà del secolo con la costruzione di palazzoni Aler. Distrutta l’antica cascina, anche il ponte fu sostanzialmente ricostruito, allargato e prolungato con un cavalcavia, così che l’assetto attuale dell’area del cavalcavia Bacula ha in realtà ben poco a che vedere con la testoriana Ghisolfa, consegnata ad un’esistenza puramente letteraria. L’umanità che nell’opera di Testori abita in prossimità del ponte e quotidianamente vi transita è la città e insieme altro da essa, dentro e fuori nello stesso tempo. Per meglio dire, è l’immagine di un’appartenenza impossibile, di un desiderio presto deluso, dell’abbraccio ingannevole e del rifiuto.
Sotto il titolo Il ponte della Ghisolfa vengono riuniti diciannove racconti – il quindicesimo è l’eponimo- collegati tra loro in primo luogo, come si diceva, dall’ambientazione in quella particolare periferia urbana, negli anni dello sviluppo industriale del dopoguerra, mentre avanza il miraggio del benessere e le campagne vengono divorate, prima ancora che dall’espandersi a macchia d’olio della città, dalla marginalizzazione della loro funzione. I protagonisti dei racconti, quasi tutti giovani, appena adolescenti o sul limitare della vita adulta, sono segnati dall’ambiente in cui sono nati e cresciuti, sono dunque a modo loro radicati in esso. Ma che significa essere radicati in un luogo che è definito soprattutto dalla negazione, né città né campagna, né cultura popolare né assimilazione piena di altri riferimenti? E’un’umanità la cui radice è l’assenza di radici: la città la ingoia, offrendo il duro lavoro che procura il gramo pane quotidiano, ma solo pro tempore, per il tempo della fatica, appunto, e poi la risospinge, come con un’onda di risacca, verso il buio urbanisticamente impreciso di quella frangia di terra violata, nei palazzoni dove non c’è comunità ma vicinanza coatta, non uguaglianza ma livellante anonimato.
Ma la comune cornice non è il solo elemento unificante. Anche i personaggi ritornano, tra un racconto e l’altro, le vicende spesso si intrecciano, senza che mai, tuttavia, compaia un narratore esterno a delucidare, collegare, reggere le fila. Ogni racconto è la storia del protagonista, il quale se la racconta vivendola. E’ questo un tratto straordinario del libro di Testori: i suoi operai ed operaie sono accanitamente riflessivi. La loro condizione di vita e le svolte che si prospettano vengono analizzate in un indefesso monologo interiore, così che, nel ritmo lento di una sintassi articolatissima, le esistenze paiono fatte soprattutto dello scrutare e riscrutare, spiegare e rispiegare i moti dell’animo che stanno tutto intorno alle azioni.
Dentro questo assillante rovello ci sono le ingiustizie, il lavoro faticoso e malpagato, il triste contesto abitativo, la mancanza di prospettive; non sta qui, tuttavia, la radicalità della posizione testoriana. La troviamo piuttosto nella dimensione morale dei personaggi, nell’averne rappresentato le piccole vicende come sede dei più elevati drammi morali. Sembra anzi che quelle vite spoglie che si consumano in un mondo altrettanto spoglio siano le più adatte a mettere a fuoco ciò che per l’autore pare essenziale, il dramma morale che la vita stessa è. Nell’umanità di Testori non c’è ombra di vitalismo innocente: i suoi popolani sono semplici ma non inconsapevoli. Il gesto nasce per lo più deciso, quindi già giudicato. In molti casi, il racconto è proprio lo spazio nel quale il soggetto fa cadere a poco a poco alibi e giustificazioni per giungere a guardare in faccia il suo operato e a prendere atto che ‘sapeva’; sapeva, non può negarlo, se fosse bene o male. Lo sapeva al di là di ogni condizionamento, e il fatto che lo riconosca con dolore non toglie il punto capitale, e cioè che quel sapere viene prima di ogni circostanza e può essere appannato ma non tolto, perché è la sua anima.
Anche Il ponte della Ghisolfa, un quarto di secolo prima de I Promessi sposi alla prova, può essere letto come una verifica del messaggio manzoniano: c’è un solo modo di rendere protagonisti gli umili, accreditarli come soggetti all’altezza del tragico. Ogni compromesso, su questo fronte, può mettere capo solo al colore locale, alla macchietta o al patetico, per restare in letteratura, a paternalismo o populismo, se si allarga lo sguardo alle sporgenze socio-culturali del messaggio.
Protagonista del racconto eponimo e del successivo è una giovane donna che sfiorisce tristemente in un matrimonio sbagliato e si accende di un nuovo amore, spintavi praticamente a forza dal marito stesso; è giustificata, dunque, pienamente giustificata… o no? “ Forse… Ma se avesse ceduto una volta come avrebbe potuto poi fermarsi? Non era una strada quella su cui un passo chiamava di forza un secondo e un secondo un terzo, fino ad arrivar giù, nel fondo? “ E più avanti: “Aveva tradito, ecco quello che aveva fatto: e se adesso poteva dirselo con tanta chiarezza significava che tutte le sofferenze e le umiliazioni di quegli anni non bastavano a giustificare, come avvicinandosi all’appuntamento si era detto e ripetuto, ciò che aveva fatto”.
La bellezza che risveglia la concupiscenza di molti, donne e uomini, è invece l’ambiguo dono che la sorte ha elargito al giovane Ivo; il quale capisce in fretta che quella può essere la via per uscire dalla miseria, per di più senza lavorare. Abiti, soldi da portare a casa e da sventolare sotto il naso degli amici del quartiere, perfino la moto. Basta non avere scrupoli insensati, basta ripetersi che il mondo è così, tutto lurido, e dunque tanto vale. Eppure anche lui avrà la sua ‘notte dell’Innominato’: ”Se dunque fuori tutto era rimasto come prima, chi poteva esser cambiato, se non lui? Non era infatti lui a sentir che qualcosa era franato e proprio quel qualcosa che fin lì aveva formato il piedestallo su cui s’era eretto? Non che un maleficio gli avesse distrutto nottetempo bellezza e fascino. Si trattava d’altro, d’un qualcosa di cui ricordava d’aver avuto sentore anche prima ma non con la forza e con la violenza d’adesso. Un sentore che s’era risolto in qualche scrupolo, in qualche esitazione e in qualche pensiero ma che poi il vento della felicità aveva spazzato via senza lasciar né strascichi, né memorie; fin lì infatti il bisogno e il piacere di vivere eran stati per lui una giustificazione così naturale di tutto ciò che faceva da non aver bisogno di proporsela: il meccanismo segreto che rassicura e rende tranquilli era scattato sempre da sé, né più né meno di ogni altro meccanismo della sua vita. Ma adesso? Adesso anche le azioni e i gesti di prima parevan risalire con le loro ombre sinistre come se qualcosa le ributtasse dal fondo buio e fin lì apparentemente tranquillo verso la superficie dell’acqua: l’acqua era la sua azzurra, trasparente eppur fetida coscienza.”
Per Ivo non ci sono le campane e il cardinale, come per Bernardino Visconti; c’è un altro tipo di sorpresa, quella di scoprirsi, lui che aveva sempre considerato l’amore solo un divertimento, innamorato, e proprio della donna che intendeva solo sfruttare. E questo amore, senza divertimento, nel pentimento e nel dolore, gli schiude un’immagine nuova del mondo e di sé.
L’amore è d’altra parte onnipresente, nell’universo giovane de Il ponte della Ghisolfa. E’ spinto dalla pulsione organica, la quale tuttavia non si presenta nella forma dell’abbandono gioioso. Le speranze sono subito deluse, dentro relazioni che risultano più o meno sottilmente degradanti. Né si può dire che la speranza voli alto, fin dal principio, come incapace di spingersi oltre il raggiungimento dell’assetto ritenuto normale della vita adulta. Si potrebbe forse dire che la vera sorpresa, quando accade, è la gioia, Anzi, la gioia è sempre una sorpresa, e non è la felicità vitalistica o la riuscita sociale. E’ invece l’imporsi inopinato di un sentimento vero, di qualcosa di pulito, capace di spezzare la rassegnazione ad essere poco, la rassegnazione alla miseria morale.
Salvo due brevi racconti, dedicati l’uno ad una coppia di sposi, l’altro a due giovanissimi innamorati, nei quali Testori ci fa respirare l’aria pura dell’autenticità semplice, della coincidenza miracolosa tra i sentimenti e il giudizio morale, il resto della raccolta potrebbe essere letto come un’antologia dei modi in cui, per dirla con Pratolini, si incomincia a rompersi il collo. E alcuni se lo rompono davvero, senza che appaia all’orizzonte una prospettiva di riscatto. A meno che, nel tempo, che è ancora il nostro, in cui le spiegazioni e le giustificazioni dei sapienti ci sottraggono colpe e insieme anche senso e dignità, il riscatto non stia proprio in quegli attimi di chiara coscienza, diamanti purissimi che ricostituiscono la possibilità del rispetto e che non mancano per nessuno. Per nessuno. Testori gioca nel suo mondo di poveri ai limiti dell’emarginazione la scommessa manzoniana, e la vince. Ci si può domandare se sia possibile un qualunque umanesimo senza questa vittoria.
A cura di:
Giuliana Zanello è nata a Milano nel 1957. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore e insegna al liceo classico di Busto Arsizio. Collabora occasionalmente con IlSussidiario.net