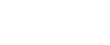MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
IL MAESTRO DI REGALPIETRA, Matteo Collura - a cura di G. Zanello
Matteo Collura: Il maestro di Regalpetra, prima pubblicazione 1996,ed. La nave di Teseo, 2019
€ 18,00 e-book €9,99
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, Adelphi, 2002
Il consiglio d’Egitto, Adelphi, 2009
Morte dell’Inquisitore, Adelphi 1992
Todo modo, Adelphi, 2003
L’affaire Moro, Adelphi, 1994
Leonardo Sciascia nacque l’8 gennaio 1921, morì il 20 ottobre 1989. Ovvero, come fa notare Matteo Collura nella biografia dello scrittore siciliano recentemente ripubblicata in occasione del centenario, la sua vita si distende tra l’anno di nascita del PCI e quello della caduta del muro di Berlino. Coincidenza, certo. Ma per lo scrittore che, in sintonia con Borges, considerava la coincidenza ‘unica scienza certa’, non irrilevante. Tra le due date scorre il gran fiume delle illusioni e delle tragedie del XX secolo, rispecchiate, secondo una lente particolarissima, nello sguardo pensoso del ‘maestro di Regalpetra’, come lo chiama Collura, nella sua biografia politica, nelle sue opere. Il racconto di Collura, chiuso ad anello tra la cronaca del funerale di Sciascia, quel funerale che egli volle cattolico e in tutto tradizionale, e la cronaca delle sue ultime ore, è di lettura impegnativa: in un ricchissimo intarsio di testimonianze dello stesso Sciascia, di articoli e citazioni delle opere, con il controcanto dei giudizi critici e delle repliche degli interlocutori nelle frequenti arroventate polemiche che in tante occasioni lo scrittore siciliano suscitò, ci scorrono davanti le tappe più drammatiche e dolorose della storia della repubblica italiana, dal compromesso storico al terrorismo, dal caso Moro al caso Tortora, alla mafia, naturalmente. La mafia che egli conosceva fin da ragazzo, annidata nella trama dei rapporti e nella mentalità di Racalmuto, suo paese natale, la Regalpetra di uno dei primi libri pubblicati. Siamo nella Sicilia occidentale, in provincia di Agrigento, a pochi chilometri dalla patria di Pirandello; nell’interno, però: Sciascia scoprirà il mare solo da grandicello, senza mai amarlo. Il suo paesaggio, quello cui rimarrà fedele per tutta la vita, quello che gli penetra l’anima tanto da diventare parte integrante della sua visione del mondo, della metafora della Sicilia come specchio del mondo, è segnato dalle aride zone interne, per vasti tratti sconvolte dalle zolfare: “colline nude, valloni rugosi, polvere e sete e quella desolazione di deserto lunare” – così Matteo Collura- e bizzarre costruzioni minerarie, spesso in rovina, e, soprattutto, tragedia umana. Lavoratori-schiavi, nudi e deformati dalla fatica e dalla miseria irreparabile, inchiodati fino alla morte là dove li avevano gettati una sorte tremenda e inamovibile e l’avidità e l’ingiustizia degli uomini, a riassumere, in un angolo sperduto di una terra che pare fuori del tempo, la ferocia della industrializzazione. Da lì era partito il nonno dello scrittore, dall’infimo gradino del caruso, che per lui non era stato definitivo: una tempra eccezionale gli aveva consentito, se non di uscire dall’inferno della zolfara, di conquistarvi una posizione diversa, quella di contabile. La zolfara, del resto, per qualcuno dei tanti che si gettavano nell’impresa sperando nella ricchezza, poteva essere anche luogo di promozione sociale… Forse, ma nella vicenda familiare di Sciascia fu un dono avvelenato. Il fratello minore, Giuseppe, non riuscì a lasciarsi quel mondo alle spalle come il primogenito, vi rimase, ad un livello ancora più alto: diplomato all’Istituto Tecnico Minerario, direttore, orgoglio del padre. Finché una domenica mattina, a venticinque anni, in quello scenario desolato si uccise. Se aggiungiamo ancora che lo sfruttamento dei giacimenti di zolfo in Sicilia si realizzò all’insegna di una sostanziale assenza di regolamentazione e controllo statale, con i Borboni prima, con lo stato italiano poi, che ciò alimentò tanto un capitalismo rapace e sfruttatore quanto la tendenza degli imprenditori ad avvalersi di ‘protezioni’, il quadro è completo e comprendiamo come nella zolfara ( esperita fin da quei primi anni di vita nei quali, per Sciascia, accade tutto ciò che è veramente fondamentale nella formazione di un uomo) si stringa il nodo che tiene insieme la vicenda biografica, le scelte politiche, i rovelli di un’intera vita, l’opera letteraria: il tema della mafia, del quale, da Il giorno della civetta in avanti, lo scrittore sarà considerato un esperto, mai prevedibile peraltro; la critica tagliente del mondo politico, tra corruzione, legami mafiosi, avidità di potere fine a se stessa; il tema più generale , che tutti gli altri comprende, della giustizia. E dunque, se lo sguardo straniato e la prospettiva straniante, atta a rivelare e rappresentare il gioco intricato e crudele delle ipocrisie, gli vengono da Pirandello, l’altro grande modello è Manzoni, e precisamente il Manzoni della Storia della colonna infame, dell’interrogazione inesausta sulla possibilità della giustizia, della letteratura intesa come dovere di indagine, come scrutinio, scrupoloso e mai pago, delle ingiustizie e di ciò che si deve fare, non certo per non commettere più errori, il che non è concesso, ma per correggere almeno i più spaventosi. Pirandello e Manzoni, dunque; quale filo li unisce? Pascal, “un Pascal da Manzoni e da Pirandello diversamente letto e con diversissimi esiti. Le ragioni del cuore che la ragione vuol trascegliere e annettersi, per Manzoni; le stesse ragioni che sfuggono alla ragione e si fondono allo spavento cosmico, per Pirandello”. Così Sciascia in una nota di chiusura a 1912+1, del 1986. Le ragioni del cuore che la ragione vuol trascegliere e annettersi: la frase rappresenta anche una descrizione dello stile – in quanto risultato di un atteggiamento mentale- di Sciascia. Uno stile in cui si avverte la sorveglianza assidua di chi ha rispetto per le parole e concepisce lo stile stesso come il modo per recuperarne intero e vero il significato; uno stile consapevole della sua funzione nel suo stringere da presso le cose, cercando la precisione del vero attraverso i mille inganni della mente. Dallo spavento cosmico, nella sempre più matura consapevolezza del nostro limite, nella sempre più lucida visione delle non confortanti direttrici della storia, solo la scrittura può salvare, recuperando al territorio dell’umano, della comprensione magnanima, dell’equilibrio, ciò che diversamente cade nel territorio del diavolo. “E’ l’alba”: sono state queste le ultime parole di Sciascia, dedicate alla luce. La luce che trovava in Stendhal, in Montaigne, in Ortega y Gasset. La produzione dello scrittore siciliano alterna costantemente due vie, l’attualità e la ricerca storica, entrambe declinate soprattutto nella forma del caso, o piuttosto dell’errore, giudiziario, da indagare in primo luogo per cercare di rendere almeno alla memoria degli uomini quello che la storia ha loro tolto , in secondo luogo per additare, muovendosi sul terreno meno invincibilmente lubrico del passato, qualche lama di luce che possa, come cadendo attraverso una persiana accostata nel gran sole della controra, illuminare un poco l’inestricabile presente. E’così per Il consiglio d’Egitto, dove il fallimento delle speranze di illuministico progresso nell’isola stinge le sue tinte dolorose sul presente e l’immediato futuro. Difficile sottrarsi alla suggestione che spinge a sovrapporre il malinconico addio a Palermo del riformatore vicerè Caracciolo, nel romanzo storico del 1963, al trasferimento di Bellodi, ne Il giorno della civetta del 1961. Ma poi, nel romanzo storico, complessa e surreale vicenda ricostruita su documenti autentici, il finale, con la barbara tortura e l’esecuzione del repubblicano Di Blasi, in un ambiente che pur sapeva di Beccaria e dei suoi scritti, rimanda inevitabilmente a Manzoni, alla Storia della colonna infame. Lo stesso sdegno, lo stesso doloroso sgomento per ciò che ‘non dovrebbe mai toccare a un uomo’, che porterà Sciascia a indagare la giustizia ingiusta in altre narrazioni di tipo storico, tra cui, ad esempio, Morte dell’inquisitore, del 1964, in cui si ricostruisce la storia dell’eretico racalmutese fra Diego La Martina. Vent’anni dopo, gli stessi temi saranno oggetto di appassionati interventi parlamentari e giornalistici sul caso Tortora, nel quale al tema del diritto calpestato si unisce l’aberrazione del pentitismo. La legge sui pentiti era stata sempre nettamente disapprovata da Sciascia, che vi vedeva una fondamentale abdicazione del diritto da cui nessuna giustizia avrebbe potuto scaturire, semmai una corruzione più grave e profonda. Dal suo angolo visuale, la corruzione gli appare del resto come inestricabilmente legata alla politica, a una politica che, attraverso una serie di slittamenti strumentali, ha perduto via via qualunque orizzonte ideale e qualunque freno etico, palesandosi come pura sete di potere. E’ qui, per Sciascia, il punto di incontro con la mafia, la quale, a suo avviso, lungi dall’insinuarsi là dove lo stato latita, coincide nei fatti troppe volte con lo stato stesso. Posizione urticante e isolata, ma sulla mafia Sciascia isolato sarà sempre, anche prima della resa dei conti finale, prima di quel giudizio sui professionisti dell’antimafia (la formula non è sua, ma la condivide) che ne farà un paria del mondo politico e intellettuale italiano.
“Prendiamo un sindaco che per sentimento o per calcolo cominci ad esibirsi – in interviste televisive e scolastiche, in convegni, conferenze e cortei – come antimafioso: anche se dedicherà tutto il suo tempo a queste esibizioni e non ne troverà mai per occuparsi dei problemi del paese o della città che amministra(…), si può considerare come in una botte di ferro. (…) Chi mai oserà promuovere un voto di sfiducia, un’azione che lo metta in minoranza e ne provochi la sostituzione? Può darsi che, alla fine, qualcuno ci sia: ma correndo il rischio di essere marchiato come mafioso…”.
Anche l’antimafia può essere solo una via per tenere saldamente il potere, manifestazioni di piazza e assemblee con studenti a sostituire i gesuitici esercizi spirituali per uomini potenti dell’allucinata parabola di Todo modo, del 1974.
Ma la circostanza storica in cui più tragicamente Sciascia si sente messo davanti alla logica spietata e immorale del potere è la vicenda del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro. Ne L’affaire Moro, del 1974, attraverso l’esame delle lettere che il presidente della DC scrisse dalla prigionia, lo scrittore sostiene la sua tesi: il Moro che scrive dal covo delle Brigate Rosse non è un uomo trasformato e sconvolto dalla paura al punto che non si possa riconoscere nelle sue parole il ‘vero’ Aldo Moro: Moro era perfettamente lucido, chiedeva di essere salvato ed aveva il pieno diritto di farlo. Il discredito gettato sull’attendibilità delle lettere fu funzionale alla tesi secondo cui salvarlo era impossibile, tesi falsa, a parere di Sciascia. Che ravvisa con raccapriccio, nella stentorea negazione di ogni trattativa, un possibile interesse a far tacere per sempre l’uomo politico pugliese da parte di settori del suo stesso partito, uno strumento per accreditarsi come forza di governo e difensori dello stato da parte degli uomini del PCI. In questo senso, Moro sarebbe stato condannato a morte dalla sua creatura, quel compromesso storico che, dal canto suo, Sciascia aveva avversato fin dal suo primo apparire in Sicilia, in quanto rinuncia a qualunque idealità politica in nome di una logica puramente spartitoria. Ma al di là della fondatezza o meno delle singole tesi, il punto centrale per cui L’affaire Moro è un grande libro è la convinzione profonda, portata avanti al di là delle simpatie politiche, che nulla valga la salvezza di un uomo, che il diritto possa sperare di essere meno ingiusto solo quando salva la pietà, o su di essa si fonda.
Il libro racconta che il brigatista incaricato di trasmettere alla famiglia le ultime volontà di Moro si trattenne a lungo al telefono, imprudentemente, sapendo di essere ascoltato dalla polizia: “Forse ancora oggi il giovane brigatista crede di credere si possa vivere di odio e contro la pietà: ma quel giorno, in quell’adempimento, la pietà è penetrata in lui come il tradimento in una fortezza. E spero che la devasti.”
E basterebbero queste righe per comprendere la distanza che separa il pessimismo cinico dalla pensosità sostenuta di chi si rifiuta alla retorica vuota e alla facile illusione. Del resto Sciascia stesso lo chiarì, a chiosa del suo percorso di uomo e di scrittore, in una delle ultime interviste: “Come cittadino sono stato talmente ottimista da fare per diciotto mesi il consigliere comunale a Palermo e per quattro anni il deputato al Parlamento nazionale. E quale miglior prova di ottimismo di quella che continuo a dare scrivendo su quella che Machiavelli chiamava la verità effettuale delle cose, e riscuotendo per questo le più violente reazioni degli stupidi, per non dir peggio? Il vero pessimismo sarebbe quello di non scrivere più, di lasciare libero corso alla menzogna. Se non lo faccio, vuol dire, in definitiva, che sono inguaribilmente ottimista”.
A cura di:
Giuliana Zanello è nata a Milano nel 1957. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore e insegna al liceo classico di Busto Arsizio. Collabora occasionalmente con IlSussidiario.net