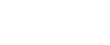MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
Daniele Del Giudice, LO STADIO DI WINBLEDON e ATLANTE OCCIDENTALE - a cura di G. Zanello
Autore: Daniele Del Giudice
LO STADIO DI WINBLEDON
ed. Supercoralli Einaudi, 2021, pp 152, € 15,00 - e-book € 6,99
ATLANTE OCCIDENTALE
ed. Letture Einaudi, 2019, pp 131, € 20,00 - e-book € 6,99
La carta di Mercatore: questo doveva essere, nelle intenzioni dell’autore, il titolo di quello che fu poi Lo stadio di Wimbledon, pubblicato nel 1983. E, come Del Giudice precisa nel saggio Considerazioni sull’animale parlante (in In questa luce,2013), “ è noto che il secondo nome di quella Carta cinquecentesca, alla base della moderna cartografia, è appunto Rappresentazione”.
Rappresentazione, dunque, Del Giudice vuole che sia la sua scrittura narrativa, oltre le distinzioni operabili all’interno della narrativa medesima, oltre quelle tra la narrativa in generale e le altre modalità di approccio al mondo attraverso la scrittura in prosa. Il senso di ciò che qui si intende per ‘narrativa’ va pertanto precisato: essa coincide in effetti con il risultato del passaggio dalla simultaneità della visione alla scrittura, alla quale il mezzo linguistico impone, in forza della sua strutturale linearità, una successione estranea alla percezione. Si apre così uno spazio, si genera una tensione dinamica tra la percezione e lo strumento espressivo, dove può prodursi la narrazione. Può, perché, ricondotta alla sua radice, sottratta a convenzioni e filtri preventivi, essa si dà non come trascrizione di un progetto già messo a punto, ma come risultato solo probabile di un’interazione.
Questo il livello di impegno teorico, di responsabilità, potremmo dire, con cui Del Giudice guida il lettore nel pensare e nel sentire degli ultimi decenni del ‘900.
Ne Lo stadio di Wimbledon, suo primo romanzo-chiamiamolo così, senza discutere il termine-, l’io narrante è impegnato in un’indagine sulla vita di Bobi Bazlen. L’intellettuale triestino, morto nel 1965, è ben noto- recentissima l’uscita postuma di un libretto di Roberto Calasso, peraltro dedicato in particolare agli anni romani di Bazlen- e basterà quindi richiamare brevemente qualche dato. Lettore vorace e appassionato, Bazlen dominava un paesaggio letterario amplissimo, specialmente nella lingua tedesca di cui aveva conoscenza perfetta; fu traduttore e consulente delle maggiori case editrici italiane; conobbe tutti gli autori importanti della sua epoca, a partire, naturalmente, dai triestini – fu lui, ad esempio, a suggerire a Montale la lettura di Svevo. Tuttavia, Bazlen non scrisse quasi nulla e in ogni caso nulla pubblicò in vita. Lettere, scritti vari, un racconto in tedesco tradotto da Calasso uscirono solo postumi: poco, in ogni caso, per farne uno scrittore, pochissimo in rapporto alla sterminata cultura letteraria, all’influenza culturale, alla sagacia di Bazlen lettore.
Da qui prende le mosse l’indagine dell’io narrante di Del Giudice, interessato a scoprire perché Bazlen non scrisse. Comincia così la ricerca intorno a un non scrittore, ricerca che lo porta più volte a Trieste e infine a Londra, anzi, specificamente a Wimbledon, sulle tracce di tutti coloro che hanno conosciuto Bobi. Attraverso i ricordi di chi ne condivise l’esistenza, si dipana in definitiva un’inchiesta sulla scrittura, su ciò che significhi scrivere e, in particolare, scrivere rispetto a vivere. Forse Bazlen non scrisse perché la sua opera fu la vita, ma attenzione, non nel senso vitalistico di un D’Annunzio, non nella dandistica costruzione di sé. L’opera di Bazlen fu la vita degli altri, l’osservazione -la lettura?- degli altri, l’infinito gioco delle combinazioni. Bazlen, nelle parole di chi lo conobbe, tra cui le celebri figure femminili montaliane di Gerti e Ljuba, univa e divideva, rompeva o favoriva relazioni. Intuiva possibilità nel fluido gioco combinatorio della vita e le spingeva delicatamente a diventare trame. Forse. Perché anche questa conclusione è solo probabile, è solo un disegno intravisto come intreccio di linee di forza tra oggetti distanti; linee la cui consistenza sta nell’occhio dell’osservatore il quale, osando una forzatura, porta alla luce una probabilità.
Con quest’ultimo rilievo siamo già nel cuore del secondo romanzo, Atlante occidentale, del 1985, ambientato in Svizzera, a Ginevra, e precisamente dentro e intorno al grande acceleratore di particelle. Dopo la Carta, l’Atlante, a confermare la persistenza di un campo metaforico su cui si cercherà di tornare brevemente più avanti. Ma intanto, per dare spessore al riferimento geografico, per suggerire il corto circuito che incendia di potenzialità metaforica la coincidenza tra la Svizzera e la sede delle più avanzate ricerche di fisica delle particelle, torniamo ancora al già citato saggio Considerazioni sull’animale parlante: “è cambiato il nostro rapporto con gli eventi, il nostro modo di percepirli in questa specie di Svizzera del mondo, cioè nella regione di circa un miliardo di persone che tra l’Europa, l’America del Nord e il versante pacifico dell’Asia godono del nostro sistema economico”.
La macchina immane dell’acceleratore , là dove tecnici e scienziati in gran numero lavorano ad esperimenti destinati a rivelare (il rivelatore è infatti lo strumento più spesso citato) qualcosa la cui esistenza si ritiene probabile, che è al di fuori della percezione ma è la verità del percepito e, rivelata, ci lascerebbe con la consapevolezza della fallacia del nostro vedere e insieme con un vedere del tutto cambiato; l’acceleratore, dunque, nel cuore della Svizzera del mondo, ovvero nel cuore del nostro mondo, di quello che nel 1985 era il nostro mondo, perfettamente compiuto e vittorioso e a un passo dallo sfaldarsi… Perché nello stesso saggio Del Giudice dichiara il suo relativo pessimismo sulla stabilità politico-sociale di quella Svizzera, così che il cataclisma cognitivo indotto dalle scoperte della fisica, che potrebbe essere, pur nella sua problematicità, un’altra conferma di superiorità e successo, appare sottilmente intriso di una sorta di nostalgia preventiva, caricato di una vena di profezia di altre fini.
Ma si tratta solo di sfumature. Il tono generale dell’opera porta il lettore a respirare l’atmosfera dell’occidente di quegli anni, così come la respirava chi fosse in essa immerso consapevolmente; non esente, quindi, dal brivido di novità deflagranti, dal senso crescente della caduta nell’insignificanza di tanto sapere, di tante parole, sui quali faceva aggio, tuttavia, l’emozione del palesarsi dell’inaudito, chiamato a rivelarsi dagli strumenti costruiti con assidua millimetrica precisione, dalla tecnologia, insomma.
Pietro Brahe è un giovane fisico italiano che lavora presso l’acceleratore di particelle, nelle viscere della terra, ma nel tempo libero ama praticare il volo, guardare dall’alto quella città di cui vive soprattutto l’invisibile sotto, mentre poco, oltre al sonno, resta alla vita in superficie, al mondo della prospettiva che consideriamo normale, e questo poco registrato soprattutto attraverso la visione fluida e a suo modo topografica degli spostamenti in automobile. Una mattina Brahe non riesce nemmeno a decollare perché il suo aereo viene danneggiato dalla manovra sbagliata di un altro pilota amatoriale, il celebre anziano scrittore Ira Epstein. Dalla traiettoria confliggente dei due aerei nasce un rapporto che via via si palesa come amicizia. Amicizia che raggiunge la sua acme e la sua fine nel giorno in cui Brahe, il cui esperimento ha finalmente rivelato la particella cercata, saluta per l’ultima volta Epstein che lascia per sempre la Svizzera ed a sua volta ha appena appreso di avere vinto un importante premio. Lo scontro fortuito dei due aerei ha incrociato le traiettorie esistenziali dei due protagonisti; essi hanno interagito modificandosi a vicenda e producendo un sentimento; ora le due traiettorie tornano a divergere, ma nessuno è come prima e in ogni caso la relazione ha prodotto qualcosa che prima non c’era, quel sentimento che è la cosa davvero importante.
Campi di forza, reti di relazioni fluide tra particelle: questo è la realtà, ogni realtà, solida o aeriforme, organica o inorganica, null’altro che un modo di disporsi dell’energia secondo un disegno sempre variabile, nell’inesausto fluire. Ma la consapevolezza di questa uniformità radicale, lungi dall’annullare nichilisticamente il valore della meravigliosa diversità dell’esistente, spinge a guardarla con rinnovato stupore, a coglierne il mistero. E mistero non è, per Del Giudice, l’oscuro e inconoscibile, bensì l’eccedenza, il nuovo, ciò che approda all’esistenza per la prima volta nella sua unicità, come prodotto probabile ma non necessario delle relazioni. Per questo è mistero il sentimento che nasce dalle relazioni, per questo è mistero il nuovo che lo scrittore produce mettendo in relazione la realtà e la lingua. Relazione che passa necessariamente attraverso di lui, così che ogni volta chi rende possibile l’esperimento lo perturba, chi chiama all’esistenza una briciola di realtà la deforma, vi imprime il suo marchio. E ciò inevitabilmente. Questa è la condizione dell’indagine, e quindi della conoscenza, del mondo fisico, oggi lo sappiamo, e sappiamo che è anche la condizione dello scrivere, come in generale dei nostri rapporti con le cose. Per questo ci è precluso il realismo degli uomini del passato e non possiamo dare della realtà una rappresentazione sottratta al frantumante gioco delle rifrazioni, se non per consapevole riduzione.
Brahe lavora per lo più di notte, ma la trascorre, giù nelle viscere della terra, a studiare la luce, quella luce che è la realtà stessa; per contro di giorno, alla luce del sole, lo sorprendiamo per lo più assonnato, come straniato. Il dettaglio è realistico, e lo sa bene chi ha fatto l’esperienza e conosce quella sensazione strana, ma nel contesto si carica di rimandi, facendo di Brahe l’emblema di chi sa che ‘la realtà non è quella che si vede’, che ‘si esauriscono i corpi in un fluire ‘, come dicono celebri versi montaliani. Del resto, in una delle sue conversazioni con Brahe, Epstein ha pure osservato che il nostro tempo è il tempo della ‘fine degli oggetti’: sappiamo che la solidità e la persistenza in una forma fissa degli oggetti non sono che apparenze legate ai limiti della nostra percezione, che la realtà è fatta di movimento follemente rapido e incessante, che l’unicità è molteplicità incalcolabile, che la solidità senza pertugi è fatta per lo più di vuoto…
Del Giudice in Pietro Brahe ci presenta l’uomo occidentale come sarebbe se sapesse quello che sanno i fisici, se lo sapesse davvero, cioè lo sentisse: se sentisse il suo passo come un fluire, con relativo disfarsi e formarsi di campi di forze, del suo corpo tra altri corpi; se sentisse l’energia forsennata che ribolle in una superficie levigata, se sentisse l’uniformità opaca ed omogenea come limite dell’occhio, che così occulta il vuoto e la luce, se avesse, in ogni momento, la coscienza della prospettiva cui la visione lo costringe e idealmente ne inserisse lo spicchio tra mille altre possibilità.
Il motivo del mutamento di prospettiva è infatti assai caro a Del Giudice, legato com’è al tema del volo, già importante in questo secondo romanzo ed esclusivo nel libro forse più celebre, Staccando l’ombra da terra, del1994. Qui importa sottolineare come la prospettiva sempre mutevole (una sorta di allerta per il lettore eventualmente tentato di adagiarsi) sia segnalata da una spia linguistica specifica, forse quella che più colpisce alla prima lettura, insieme al lessico tecnico e scientifico, ovvero l’uso dei tempi verbali. Si osserva in Del Giudice un originale alternarsi di passato remoto e passato prossimo, al di fuori dell’opposizione canonica tra tempi narrativi e tempi commentativi, come al di fuori del dialogo. Nelle stesse parti narrative, in cui il narratore onnisciente riferisce atti e pensieri dei personaggi, il passato prossimo si inserisce a tratti, a blocchi o a scene, interrompendo il fluire del passato remoto e della narrazione. Senza altri segnali testuali, sappiamo così che il narratore si è eclissato, per lasciare spazio all’occhio o al sentimento di sé del personaggio.
Si diceva della ricorrenza dell’immaginario topografico, della carta o dell’atlante. Si tratta di una rappresentazione del mondo che, unita al carattere fortuito, temporaneo e ramificato delle relazioni, può suggerire una vicinanza a Calvino. E certo Calvino, primo prefatore di Del Giudice, è una presenza importante; si tratta però di un Calvino non seguito ma assimilato e superato, così che il mondo di Del Giudice è molto lontano dal labirinto calviniano. Se in quest’ultimo, infatti, a incontrarsi e separarsi fortuitamente, a perdersi lungo imprevedibili e casuali sentieri, del mondo o del sapere, sono pur sempre soggetti definiti, sicché labirintico è il reale, mentre l’uomo che lo percorre è stabile, e tanto più stabile quanto più illuministicamente razionale, il soggetto di Del Giudice, come si è cercato di dire, non si vive come esterno alle relazioni -nemmeno, notiamolo di passata, quando stacca l’ombra da terra, nel volo-, al contrario ne è continuamente modificato; e non si muove all’interno di una realtà fluida, ma fluisce con essa. Tuttavia, come si è già notato, non può farlo senza modificarla, senza turbarla a sua volta. Insomma, dopo avere tentato in ogni modo di mettere a tacere quella che chiamiamo soggettività, dopo averle tolto la terra sotto i piedi per lasciare alla realtà il suo disegno oggettivo, deve arrendersi all’inevitabile presenza di qualcosa che la tocca e la modifica, e la modifica in modo diverso da come altro farebbe. E quel qualcosa si può chiamare ‘io’. Un ‘io’ a cui, come già aveva detto con chiarezza Calvino nella prefazione a Lo stadio di Wimbledon, si arriva per sottrazione. Un ‘io’ che si presenta ancora, dunque, come eccedenza, come mistero.
A cura di:
Giuliana Zanello è nata a Milano nel 1957. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha insegnato al liceo classico di Busto Arsizio. Collabora occasionalmente con IlSussidiario.net