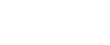MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
RAGAZZI DI VITA, P.P. Pasolini - a cura di G. Zanello
Pier Paolo Pasolini: RAGAZZI DI VITA
ed. Garzanti 2014, 256 pp, € 13,00 e-book € 9,99
I motivi che portarono, nel 1955, a mettere sotto processo l’autore del romanzo Ragazzi di vita, allora fresco di stampa, per oscenità - legata all’onnipresente turpiloquio e agli allusi episodi di prostituzione maschile- sono per noi ormai del tutto improbabili. E questa stessa sensazione di irrealtà basta da sola a testimoniare la profondità del solco che separa il costume attuale da quello dell’Italia di allora. Se invece guardiamo al piano della denuncia sociale, la realtà rappresentata nel romanzo si dissolse in pochi anni, come lo stesso scrittore ebbe modo di osservare con la sua abituale acutezza. Sotto questi aspetti, dunque, il libro è inattuale, diciamo pure superato, se non per l’interesse strettamente documentario relativo alla vita delle periferie romane nei primi anni del secondo dopoguerra. Da un punto di vista letterario, resta il fascino dell’operazione linguistica, l’immersione totale nel gergo dei ragazzi di strada, nel loro romanesco di borgata (per il quale l’autore fornì anche un glossario) fedelmente riprodotto nei dialoghi e impastato con la lingua colta nelle parti del narratore, in un amalgama perfetto.
Ma questi scarni preliminari, come ben si vede, propongono già una contraddizione: quella tra un’ambizione narrativa minimale (‘Non ho voluto fare un romanzo ma un documentario’, dichiarò lo stesso Pasolini – anche qui complicando le cose, nel momento in cui trasferisce di botto nella letteratura un concetto cinematografico, a un’altezza cronologica in cui al cinema non si era ancora avvicinato) e un’operazione linguistica letteratissima, di quelle di cui era alto estimatore, e raffinatissimo critico, Gianfranco Contini. Contraddizione da cui vale la pena di partire per indagare che cos’altro c’è, in questo primo romanzo pasoliniano, che cosa ne fa un grande libro, per che cosa importa leggerlo oggi, sfrondato l’interesse contingente. Una delle tante contraddizioni – probabilmente necessarie- di un intellettuale che testimonia una passione inesausta per la realtà, passione che non è in primo luogo volontà di impadronirsene con l’analisi e che è ben di più di un tono emotivo: si tratta invece di un presupposto per così dire totale, di uno sguardo che costituisce già un giudizio di partenza; esso esclude non solo la possibilità teorica ma anche l’ammissibilità etica dell’esame asettico, della catalogazione sociologica a freddo come della interpretazione sistematica, non aporetica. L’osservatore è in gioco, piagato dal dolore personale e da quello osservato, acceso dell’amore per la vita proprio e altrui; getta nell’agone (esplicitamente: il concetto è mostrato con evidenza visiva dalle epigrafi letterarie che aprono la maggior parte dei capitoli, in cui troviamo, tra gli altri, Belli e Dante) lo strenuo confronto tra una cultura amata e continuamente interpellata e l’urto della realtà, amata anch’essa fino allo struggimento. La scelta della mimesi spinta all’oltranza, nel realizzare compiutamente le ambizioni che erano state del verismo, le denuncia come impossibili e forse illegittime, rovesciandole in un movimento che non è quello di chi si ritrae ai margini del reale (sulle rive della fiumana, per citare Verga), onde rappresentarlo senza emettere giudizi, ma di chi vi si getta a capofitto, non lasciando da parte la propria cultura di partenza ma portandola dentro il viaggio, alla ricerca di una immedesimazione che è insieme ricerca della verità di sé e che ha il sapore del sacrificio.
Com’è noto, il romanzo è costituito di una serie di episodi, o scene, in cui si muove un folto gruppo di bambini e ragazzi delle borgate romane; il tempo della storia occupa una decina d’anni circa, dalla fase finale della guerra all’avvio tumultuoso della ricostruzione, anni nei quali alcuni di questi ragazzi vengono seguiti nel passaggio dall’infanzia alla giovinezza. Si tratta di una narrazione corale, nella quale tuttavia prendono rilievo, di volta in volta, figure diverse, e in cui è possibile rintracciare un personaggio principale, il Riccetto, con il quale il romanzo si apre e si chiude. Sotto questo profilo, Ragazzi di vita può anche essere considerato un romanzo di formazione, intendendo la vicenda del Riccetto come emblematica e riassuntiva di una condizione generale. E la formazione del Riccetto, a sua volta, può essere definita dall’arco che collega due episodi, del resto tra i più noti, collocati rispettivamente alla conclusione del primo e dell’ultimo capitolo: il Riccetto, poco più che bambino, rischia la vita per salvare da annegamento nel Tevere una rondine; il Riccetto, ormai ventenne e reduce dall’esperienza del riformatorio, al contrario evita di mettere a repentaglio la vita per salvare dalle acque dell’Aniene il piccolo Genesio. Se un tempo, dimentico di sé, tra la stupefazione e i lazzi dei più grandi, si era gettato in acqua per salvare la rondine, perché era così bella, ora che è cresciuto non solo non cerca di salvare Genesio, ma non si ferma neppure a confortarne i fratellini disperati, che abbandona alla solitudine di un mezzogiorno infuocato sulle rive del fiume. E se, alla fine del secondo capitolo, quello di cui è l’eroe eponimo, quando scopre che la sua casa è crollata e sua madre è morta, scoppia in un pianto dirotto, nell’ultimo, vedendo sparire la testolina del ragazzo, al pianto arriva solo vicino, poi ‘taja’, dicendosi :’Io voglio bene, al Riccetto’.
Come si è compiuto, dunque, questo percorso di formazione? Potremmo dire che si passa da una vitalità prorompente, capace di oltrepassare le condizioni ambientali più negative con una carica potente di apertura e di desiderio, vibrante all’unisono con ogni raggio di bellezza, reperito anche nei contesti più degradati, a una vitalità prepotente, ormai chiusa nella preservazione di se stessa. Per la storia personale non si danno spiragli, si va verso l’amputazione dell’umano. E allora la belliana ‘Commaraccia secca …che arza er rampino’, epigrafe e titolo dell’ultimo capitolo, pare attagliarsi, ancor più che alla morte di Genesio, a quest’altra morte, alla morte dell’umano, all’autoamputazione che ci riguarda tutti, al morire nell’illusione di salvarsi la vita. Appare così in piena luce il potente ossimoro per cui al titolo del romanzo, Ragazzi di vita (cioè, come spiegò l’autore, affamati di vita) si contrappone quello dell’ultimo capitolo, La comare secca, appunto.
E’ stato giustamente e suggestivamente notato che questo passaggio ha una sorta di correlativo oggettivo nel mutamento di ambientazione, dal Tevere all’Aniene, il fiume delle periferie prive di qualunque identità e grandezza. Elementi caratterizzanti del paesaggio sono, oltre alle case (palazzi fatiscenti, casette minime tutte disperatamente uguali, miserabili baracche: sempre inadeguate, sovraffollate, piene di ubriachezza e violenza e vuote di cibo, dove i ragazzi non stanno quasi mai), macerie, spazzatura e acqua. L’acqua del mare, al lido di Ostia, meta delle rare domeniche in cui nelle tasche c’è qualche moneta, e poi l’acqua del Tevere e dell’Aniene. Entrambi segnati dal degrado - oleosi e ingombri di rifiuti nella corrente e sulle rive-ma con una accentuazione a sfavore del secondo, il fiumiciattolo di periferia nel quale corpi magri e affamati, a volte anche malati, si immergono a cercare frescura, letteralmente nuotando nella spazzatura e negli scarichi industriali; poi quei corpi si stendono al sole sulla grama erba della riva; e l’erba è sempre, inesorabilmente, qualificata come bruciata e sporca. Non a caso il capitolo intitolato Il bagno sull’Aniene reca in epigrafe due terzine del canto XXI dell’Inferno, là dove il comico dantesco tocca i suoi vertici: Traiti avanti, Alichino, e Calcabrina / - cominciò egli a dire- e tu, Cagnazzo; / e Barbariccia guidi la decina./ Libicocco vegna oltre, e Draghinazzo,/ Ciriatto sannuto, e Graffiacane./ E Farfarello, e Rubicante pazzo. L’Aniene come fiume infernale, di cui si ricordano non i dannati, che in esso soffrono, ma i padroni di casa, che vi si trovano a proprio agio nella loro allegria grottesca, caotica e violenta. Bastano poche battute iniziali del capitolo per illustrare la corrispondenza: ” -Tengo na fame che me cago sotto,- gridò il Begalone. Si tolse la canottiera, in piedi sull’erba zellosa, pestata contro la scarpata dell’Aniene, tra le fratte carbonizzate, si sbottonò i calzoni e si mise a pisciare come si trovava. -Qui pisci?- gli gridò il Caciotta…”.
Se nelle prime pagine del romanzo le macerie sono forse prevalenti, più avanti dilagano spazzatura e scarichi inquinanti: come dire, lo sviluppo visto dal basso. Un basso che per i personaggi è la casa, da cui non desiderano uscire: non ci sono progetti che vadano al di là del lavoro del tutto occasionale- e irregolare- o dell’espediente per mettere insieme pochi soldi, immediatamente spesi. Come non c’è storia personale, così la storia collettiva è uno scenario lontano privo di significato, un rumore di fondo, come quello dei carrarmati di cui si ode il rombo nella prima e poi nell’ultima pagina. E quando la storia in qualche modo aggancia uno dei luoghi dei ragazzi di vita, quando per caso un brano di periferia si avvia al riscatto, non è più posto per loro. Tutto troppo pulito, troppo ordinato, pensa con malinconia il Riccetto, contemplando la nuova veste del quartiere della sua infanzia e la ristrutturata fabbrica che era stata il teatro della sua prima impresa, il saccheggio del Ferrobedò con cui si apre il romanzo. Niente progetto di vita personale, niente storia collettiva, niente adulti di riferimento: gli adulti sono padri violenti e alcoolizzati o piccoli imbroglioni, versione invecchiata ma non cresciuta dei ragazzi di strada. I padri si sfuggono e si dimenticano. Solo Genesio, il più riflessivo di tutti, era arrivato a emettere un giudizio, a fare un progetto a lunga scadenza: un attimo prima del bagno nell’Aniene in cui troverà la morte, annuncia ai fratellini con cui è scappato di casa per evitare le botte del padre bestialmente violento: “Quando saremo grandi lo ammazzeremo.”
Ma in genere tutto è appiattito sull’istante, sulla pulsione vitale, e di questo, e non altro, è fatto il linguaggio. Che, come quello del Belli, è gergo deformante e aggressivo, ma di quello del Belli non ha, e non potrebbe avere, l’escursione tematica: questi ragazzi non criticano gli altri né la società, non confrontano la loro sorte con quella di nessuno, se non, all’occasione, esplodendo in insulti gratuiti contro il proprietario di un’auto costosa o contro una donna riccamente abbigliata. Il resto è espressione rudimentale di reazioni a pulsioni elementari, è gioco relazionale ridotto al grado minimo del turpiloquio. E sulle loro bocche l’autore altro non mette. Il resto è affar suo, e nelle parti riservate al narratore, in un trapasso finissimo che non mostra punti di sutura, quello stesso linguaggio lievita in un amalgama ben più ricco e straordinariamente naturale (niente a che vedere con il pastiche gaddiano, per intenderci), come se lo scrittore lo mettesse in grado di sciogliersi, e dire tutta la gioia, tutto il dolore, tutta la delusione e la commozione che normalmente restano ingorgati, stretti nel nodo della parolaccia. Ed ecco allora spiegarsi, sopra i cumuli di spazzatura o nei cantieri abbandonati, cieli straordinari, delicati trapassi di stagioni, grandiosi tramonti: tutta la bellezza del mondo; o tutta la tenerezza che può suscitare la vista di un bambino, per quanto derelitto: “Mariuccio, ch’era ancora così piccoletto che nemmeno aveva cominciato ad andare a scuola, se ne stava a giocare, tranquillo, accucciato col sederino sui talloni, con due o tre formicole, che stuzzicava con uno zeppo.”
Impeti di gioia fisica che erompono in canzoni sgangherate o risa scomposte; nodi di commozione che si fanno faticosamente strada in roche parolacce; il mondo rappreso nell’istante, senza memoria; una vita potente ma fragile, con niente dietro e niente davanti: solo vita, provvisoria e trascurabile, eppure struggente, adorabile e sacra; la più bassa di tutte, e per ciò stesso lo specchio di tutte. Di questo essere specchio della condizione umana allo stato puro, senza quell’abito per nascondersi che Adamo implorò dopo la caduta, questi ragazzi non sono consapevoli; in ciò sta il loro fascino, come anche la loro ultima irraggiungibilità . Sono sacri, appunto, separati. A questa separatezza, da cui promana a noi un necessario monito, Pasolini ha eretto il suo prezioso monumento.
A cura di:
Giuliana Zanello è nata a Milano nel 1957. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha insegnato al liceo classico di Busto Arsizio. Collabora occasionalmente con IlSussidiario.net