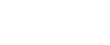MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
CINQUE STORIE FERRARESI (G. Bassani), a cura di G. Zanello
Giorgio Bassani, Una lapide in via Mazzini, in:
CINQUE STORIE FERRARESI
Universale Economica Feltrinelli, 2016,
224 pp, € 10,00
Agosto 1945. Sotto il sole a picco del primo pomeriggio, nel cuore della città padana mutata in deserto dall’ora e dall’afa, un operaio si affatica attorno a una grande lastra di marmo, una lapide gremita di nomi, centottantatré per la precisione, una fila interminabile che spiega le proporzioni del manufatto, esteticamente discutibile oltre che difficile da porre a dimora, là sulla facciata del tempio israelitico cui è destinato. A poco a poco, col volgere dell’ora, alle spalle dell’operaio si forma un capannello di gente che commenta a bassa voce – ebrei, deportati, Germania-, finché d’un tratto si dà una grottesca apparizione: un uomo molto grasso, recante in capo un incongruo colbacco di pelo. “Geo Josz? “– proferisce indicando il lungo elenco; e poi, nel silenzio rifattosi compatto, spiega che, essendo lui Geo Josz e con ogni evidenza non essendo morto, la lapide andrà rifatta…
Nessuno, dapprincipio, lo riconosce. Poi, “Sì, uno di quei ragazzi appartati – cominciavano a ricordare, stringendo le labbra e corrugando la fronte-, non più di una decina fra tutti, che per aver troncato forzatamente ogni rapporto di studio con gli ex compagni di scuola fino dal ‘38, ed avere anche smesso, di conseguenza, di frequentarne le case, d’allora in poi non si erano più visti in giro che di rado, ed erano venuti su con certe facce strane, tra impaurite, selvatiche, e sdegnose, che a rivederle ogni tanto in fuga, chine sul manubrio di una bicicletta (…), le persone, turbate, preferivano dimenticarsele.” “Era tornato quando nessuno più l’aspettava. Che cosa voleva, adesso?”.“ E’ vero – ammettevano- : loro avevano preso la tessera, la famigerata tessera della Repubblica di Salò. Tuttavia per civismo, l’avevano presa, per pura carità di Patria. E non prima di quel fatale 15 dicembre del 1943 che aveva segnato la fucilazione simultanea, in pieno centro, di ben undici ferraresi, e il successivo scatenarsi in tutto il resto d’Italia della non mai abbastanza deprecata lotta fratricida”. E della razzia degli ebrei, consegnati ai tedeschi dai loro concittadini, che li conoscevano bene e ne conoscevano ogni probabile rifugio.
Terza delle Cinque storie ferraresi , Una lapide in via Mazzini , a partire dall’inopportuna apparizione di un sopravvissuto alla strage dei deportati, campisce un impietoso affresco della borghesia cittadina : acquiescenza, pavida o interessata, o inconfessabilmente soddisfatta, quando non attivamente cooperante, di fronte all’emarginazione della comunità ebraica, all’umiliazione dei suoi facoltosi commercianti e dei suoi affermati professionisti; ancora acquiescenza pavida di fronte alle deportazioni, non esente da complicità, almeno nell’assicurarsi i beni dei deportati messi all’asta; paura di fronte ai vincitori, sentiti solo come i nuovi padroni nella partita a scacchi della storia, i nuovi forti di cui garantirsi l’appoggio, in vista dei propri interessi e della propria quiete, in primo luogo seppellendo il passato. Imperdonabile la sfacciataggine con cui Geo Josz si permette di ripresentarsi vivo, di distruggere l’illusione che la parte forse più ignominiosa di quel passato sia totalmente incenerita, senza testimoni!
Uscito per la prima volta nel 1952, il racconto fu poi inserito nella raccolta che, pubblicata nel 1956, vinse lo Strega di quell’anno. La prima pubblicazione di Se questo è un uomo è del 1958; e colpisce la coincidenza per cui, negli anni in cui Primo Levi non riusciva a far accettare dall’ambiente editoriale l’insopportabile verità della sua esperienza e della sua opera, Bassani scriveva della guerra combattuta a Ferrara contro il testimone Geo Josz , che si ostinava così sgradevolmente a non corrispondere alla buona volontà dei concittadini e a tormentarli con gesti incomprensibili e un’intollerabile propensione a raccontare.
E probabilmente a quel clima, dominato da una generale, magari non del tutto cosciente ma non per questo meno forte, volontà di rimozione, si deve anche, almeno in parte, la prospettiva critica prevalente, per cui l’opera fu letta come memoria elegiaca, in chiave proustiana e decadente. Attardata, in ogni caso, rispetto alle ambizioni realistiche e politico-civili della letteratura del dopoguerra, nel contenuto come nella forma: rievocazione struggente ed elegante, condotta sul filo di un tempo misto che ondeggia perpetuamente tra presente e diversi gradi di passato; e Ferrara, quasi una dannunziana città del silenzio, nelle descrizioni particolareggiate e indugianti di paesaggi, stagioni e monumenti.
Certo la cultura italiana degli anni trenta, letteraria e artistica (Bassani fu allievo di Longhi), costituisce un retroterra rilevante dello sguardo con cui lo scrittore filtra quel mondo, così come la lezione di Proust, nel trattamento del tempo della narrazione, nello stratificarsi della memoria per graduali trapassi, nel conseguente, coerente complicarsi ed avvolgersi della sintassi. Tuttavia, ciò non è tutto, o almeno, può essere letto e compreso in una prospettiva che, senza negarli, risignifichi profondamente anche l’evocazione estetizzante, anche l’abbandono nostalgico.
Si diceva che Una lapide in via Mazzini risale al 1952; ma la data del 1956, quando il racconto fu inserito nella silloge delle Cinque storie ferraresi, deve essere assunta come decisiva. In un insieme compatto, dove luoghi, fatti, personaggi si richiamano da un racconto all’altro, tratteggiando, per andirivieni interrotti e rivelazioni quasi casuali, una ideale storia della città dagli ultimi decenni dell’800 al secondo dopoguerra, occupa la terza posizione, ovvero il centro. Ne è insomma il cuore, pulsante e radiante, da cui partono raggi sottili che, come fili di una rete saldissima, stringono tutte le vicende, minime o gravissime, nel cerchio di una domanda terribile. Lo sterminio è sempre lì, nel cuore delle cose di ieri e di oggi, nelle luci morbide, nelle superbie e nelle umiliazioni, nelle ambizioni e nelle stanchezze, nella ricchezza e nella miseria. Come Geo Josz, che nel suo bisogno di gridare l’indicibile orrore, sembra essere dappertutto, ovunque urticante e fastidioso, tra i vecchi fascisti circospetti come tra i recenti convertiti, come anche tra i partigiani del CLN, alfieri di una nuova era che forse tanto nuova non sarà, se Geo Josz è insopportabile anche per loro.
Del resto, è il ’56, l’anno della rivolta d’Ungheria. Figlio di ebrei ferraresi, Bassani era nato a Bologna nel 1916; poi, a Ferrara, l’infanzia, la scuola, l’emarginazione a causa delle leggi razziali, il carcere per antifascismo. Dopo il carcere, la resistenza e il trasferimento a Roma. Ma nel ’56, anche a prescindere dai fatti d’Ungheria, le speranze di rinnovamento morale sono già cadute: le posizioni sociali sono state mantenute o recuperate, le credibilità restaurate, i rapporti di potere riconfermati. Anche in letteratura pare chiusa la vicenda del neorealismo, mentre all’abbandono di quella prospettiva corrisponde la ricerca di altri lidi, via dalla storia, via anche dal romanzo.
Ebbene, proprio in quest’anno Bassani propone cinque racconti che insieme formano un romanzo, un primo embrione di quel romanzo di Ferrara in cui negli anni tardi vorrà far rientrare tutta la sua narrativa; e questi racconti si chiamano storie, con un recupero terminologico che, in quel contesto culturale, non può passare come casuale. In più, la città padana che in una prima giovanile raccolta era designata come ‘città di pianura’, qui conquista il nome proprio, la determinazione specifica, diventa Ferrara. Ad abundantiam, notiamo che Geo Josz, certo letterariamente trasfigurato, è ispirato a una persona reale, Eugenio Ravenna, con la famiglia di Bassani anche imparentato; si trovava in carcere a Ferrara quando ne furono prelevati alcuni prigionieri, portati via per essere giustiziati nella strage di cui Bassani narra nell’ultima delle Cinque storie, Una notte del ’43; deportato con tutta la famiglia ad Auschwitz-Birchenau, ne tornò solo e lesse il suo nome sulla lapide commemorativa ( si trattava di un omonimo).
Come si vede, non è l’intenzione realistica a mancare, come testimoniato, del resto, dalle scelte stilistiche, che vedono la narrazione emergere dall’inesausto chiacchiericcio cittadino (e il Caffè della Borsa, allora, deve essere considerato tra i personaggi principali), in cui si scioglie la voce del narratore. Che se il colorito non è veristico, ciò è necessitato in primo luogo dalla materia, dall’obiettivo puntato sulla borghesia di una antica città di provincia e sul suo culto delle forme, sul suo dire e non dire, alludere, abilmente travestire. Quanto alla nostalgia, al senso struggente di ciò che è irrimediabilmente distrutto e perduto, ebbene, nel racconto caratterizza marcatamente Geo Josz, il quale si dispiace, all’arrivo, di vedere le mura spogliate della loro splendida corona di alberi, così come si addolora di tutto ciò che in città è scomparso, cambiato. Perché Geo la rivorrebbe, la sua città di prima, la sua vita di prima. La nostalgia, allora, non è abbandono estetizzante o evasione nell’idillio, ma piuttosto il lascito di una ferita crudele, di uno strappo violento. Ed è anche un’altra cosa: la consapevolezza che la sparizione delle cose, delle dimore e delle vie, agevola la cancellazione, insieme a ogni altra memoria, anche di quella dei morti e dei torti, degli inauditi torti.
E poi la nostalgia bassaniana è anche il segno di un amore, dell’amore desolato di chi si sente appartenere a un luogo ben sapendo, o traumaticamente scoprendo, che quella appartenenza gli viene negata; di chi ha dovuto imparare che confidenza e amicizia possono cadere in un lampo, svelandosi non più che quinte di teatro; di chi è vissuto sentendosi, implicitamente o esplicitamente, accusato di superbia perché sempre un po’ fuori, di inganno perché insinuatosi troppo dentro.
Al centro delle Cinque storie ferraresi, Una lapide in via Mazzini fora la nebbia avvolgente, la coltre di mezze tinte, la maschera rassicurante di una agiata borghesia padana del secolo scorso con le sue domande insostenibili. E se lo scandaglio di un caso personale, come efficace reagente, forza ad emergere la tabe morale di un’intera città, la città stessa, e proprio in forza della sua irripetibile unicità mai stemperata nell’astrazione dell’allegoria, si fa specchio della condizione umana. Dove l’oscurità s’aggira e d’un tratto, aiutata da viltà e paura, esplode in odio e distrugge in breve momento ciò che secoli interi avevano pazientemente costruito. Così violento, così feroce e insensato, quest’odio, da lasciare poi sbigottiti e increduli, intenti a esorcizzarlo come esito impazzito del perseguimento di meschini interessi, o a seppellirlo nell’oblio come i mostri che spaventano le notti dell’infanzia. E non c’è ricostruzione o spiegazione che illumini fino in fondo quell’oscurità, non c’è amara rivelazione che permetta di dire l’ultima parola. Per questo la scrittura aggira, insegue, ritorna su se stessa: allude e lascia capire che qualcosa, per resistere, si potrebbe pur fare; per questo si china con dolce malinconia su tutta la bellezza che pure c’è, in cui gli uomini hanno bene la loro parte. Ma da dove vengano, nella loro prima radice, accecamento e rovina; da dove venga Caino e perché precisamente un certo giorno si avventi su Abele: la domanda rimane aperta, per ogni generazione, fino al nostro oggi.
A cura di:
Giuliana Zanello è nata a Milano nel 1957. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha insegnato al liceo classico di Busto Arsizio. Collabora occasionalmente con IlSussidiario.net