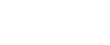MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
LA COGNIZIONE DEL DOLORE, C.E.Gadda - a cura di G. Zanello
LA COGNIZIONE DEL DOLORE
di Carlo Emilio Gadda
Biblioteca Adelphi, 2017
5ª ediz., pp. 381, € 24,00
Il moto all’interno di un labirinto può essere vano, tuttavia può essere anche accattivante e, in ogni caso, è agevole, fluido, come stanno a dimostrare l’inesauribile danza dell’Orlando Furioso o la leggerezza della narrativa di Calvino; ma se il mondo, fuori e dentro di noi, non è l’aprirsi sempre nuovo, seppure, eventualmente, con lungo giro su di sé ritornante, di invitanti vie e promettenti incroci, bensì un gomitolo, o spoletta, che una mano misteriosa abbia improvvidamente aggrovigliato, allora il moto è impedito, ogni slancio trova un intoppo, gli sforzi per procedere si tramutano in più stretti viluppi. Ogni moto finisce nell’immobilità esasperata o disperata. O nello strappo violento.
La cognizione del dolore documenta, come si sa, ad ogni livello del fare letterario, la pertinenza dell’immagine del groviglio, tanto spesso riproposta dallo stesso autore. L’ingegnere hidalgo Gonzalo Pirobutirro vive in un’agitazione penosa, nel perenne rovello in cui tenta di disbrogliare la matassa delle cause che hanno condotto la sua vita al fallimento, ovvero all’impossibilità di muoversi come a casa propria nel mondo, di sentirlo amico, di sentirsene, se non amato, almeno legittimo abitante. Richiamiamo sommariamente alcuni nodi del contenuto, del resto ben noti e spesso analizzati: Gonzalo vive con la vecchia madre, dopo aver perduto il padre e, in guerra, il fratello. Il dolore per la perdita del fratello è devastante, un muro alzato tra Gonzalo e la vita, e non solo per l’affetto che li legava e per quanto di insopportabilmente violento e innaturale è nella sua fine. Ad aggiungere strazio a strazio è il diuturno spettacolo del dolore della madre, fonte di sentimenti ambivalenti: da un lato il dolore per il dolore altrui, per la sofferenza che consuma la madre tanto amata; dall’altro la disperazione, perché la stessa immedicabilità di quel dolore sancisce l’insufficienza a consolare del figlio rimasto, è vivo documento, dimostrazione patente di qualcosa che Gonzalo nel suo intimo crede di sapere, e cioè che il morto era il migliore, che il vivo è il figlio mal riuscito. E la madre, col suo lutto inestinguibile, è allora per Gonzalo anche l’immagine della sua esclusione, della sua condanna, del suo rancore. Rancore che, mai esplicitamente attribuito a questa causa tragica e profonda, viene invece convogliato verso un altro oggetto di irosi rimuginii, in questo caso pronti ad esplodere in frequenti, parossistiche verbalizzazioni: la casa, o villa, di campagna, pretenziosa e scomoda, in cui il padre ha dissennatamente profuso le risorse economiche della famiglia, condannandone così i membri a una vita di ristrettezze; quella casa ormai squallida e pericolosamente solitaria in cui la madre si ostina a trascorrere la stagione estiva, al di là di ogni ragionevolezza, circondata da paesani che, in teoria adibiti a qualche mansione agricola o domestica, in realtà sfruttano la generosità della donna, sempre più fragile e sola, ma sempre ostinatamente legata ad un suo ideale di decoro sociale (la villa) e, in stretta connessione, di paternalistica benevolenza verso gli umili; ideale che la realtà rivela inesorabilmente come illusione, nella decadenza ben poco decorosa della casa e nella povertà della vita dei suoi abitanti, come, sull’altro versante, nella bassa astuzia sfruttatrice dei popolani. Contro questi umili, che per lui sono solo disgustosi lestofanti, Gonzalo avventa la sua ira incontenibile; ma, nei momenti di calma, in lunghe sequenze affidate al monologo interiore, la localizzazione specifica del disgusto si rivela solo occasione, elemento catalizzatore che conduce allo scoppio; il disgusto in realtà è generale, ha accompagnato l’ingegnere hidalgo in tutta la sua esistenza, fin dall’infanzia, oppressa dall’assedio delle mille angherie inflitte dall’autoritarismo stupido e dall’allegria idiota, ma soprattutto dall’ipersensibilità dell’olfatto, che affligge con effluvi sgradevoli ogni occasione di umana convivenza. Com’è noto, dopo una ennesima sfuriata nel corso della quale licenzia il fattore-custode, Gonzalo riparte per la città, lasciando la madre sola, mentre scende la sera. Durante la notte, la donna verrà aggredita nel suo letto e ferita, si suppone mortalmente. Si suppone, perché qui la Cognizione si interrompe definitivamente.
Un uomo fallito, travolto da nevrosi, rancori, disgusti, al punto da poter essere senza difficoltò immaginato – e da immaginarsi- come autore di un delitto, e non di un delitto qualunque, bensì di un matricidio. E che, in tante occasioni, ha già consumato parricidi verbali, culminanti nella profanazione del ritratto del padre, atto che Contini mette in relazione con il celebre precedente proustiano di mademoiselle Vinteuil. Un uomo sotto il cui sguardo corrosivo, nelle cui parole sferzanti fino al delirio, il mondo si disintegra in escrementi immondi, gli uomini sono mostri grotteschi, la società svela la sua idiozia, nei casi migliori, la sua criminalità in quelli peggiori. D’altro canto, non si dà alcun matricidio, ma le circostanze dell’aggressione alla madre bastano a fornire alimento al senso di colpa per averla abbandonata, per avere forse anche desiderato la sua morte, così che vedessero la fine anche la tortura e l’insensato dispendio della villa in campagna. Né il titolo, mutuato da Schopenhauer, lascia illusioni sulla visione del mondo che, per suo tormento, affligge Gonzalo Pirobutirro, nitidamente enunciata soprattutto nella parte seconda del romanzo:
“Questa perturbazione dolorosa, più forte di ogni istanza moderatrice del volere, pareva riuscire alle occasioni e ai pretesti da una zona profonda, inespiabile, di celate verità: da uno strazio senza confessione.Era il male oscuro (da qui il titolo del celebre romanzo di Giuseppe Berto, n.d.r.) di cui le storie e le leggi e le universe discipline delle gran cattedre persistono a dover ignorare la causa, i modi: e lo si porta dentro di sé per tutto il fulgorato scoscendere d’una vita, più grave ogni giorno, immedicato.”
“Per intervalli sospesi al di là, due note venivano dai silenzi, quasi dallo spazio e dal tempo astratti, ritenute e profonde, come la cognizione del dolore: immanenti alla terra, quandoché vi migravano luci ed ombre. E, sommesso, venutogli dalla remota scaturigine della campagna, si cancellava il disperato singhiozzo.”
“Cogliere il bacio bugiardo della Parvenza, coricarsi con lei sullo strame, respirare il suo fiato, bevere giù dentro l’anima il suo rutto e il suo lezzo di meretrice. O invece attuffarla nella rancura e nello spregio come in una pozza di scrementi, negare, negare: chi sia Signore e Principe nel giardino della propria anima. Chiuse torri si levano contro il vento. Ma l’andare nella rancura è sterile passo, negare vane immagini, le più volte, significa negare se medesimo. Rivendicare la facoltà santa del giudizio, a certi momenti, è lacerare la possibilità: come si lacera un foglio inturpato leggendovi scrittura di bugie. Lo hidalgo, forse, era a negare se stesso: rivendicando a sé le ragioni del dolore, la conoscenza e la verità del dolore, nulla rimaneva alla possibilità. Tutto andava esaurito dalla rapina del dolore. Lo scherno solo dei disegni e delle parvenze era salvo, quasi maschera tragica sulla metope del teatro.”
Il discorso potrebbe chiudersi qui. La cognizione del dolore, della vita e del mondo come male, mette capo all’inazione, dopo che si è bevuto fino alla feccia il calice dei fallimenti o delle perversioni di ogni volontà. La realtà non è armonia sensata né affascinante, per quanto insensato, labirinto. E’un groviglio di nodi verminosi, in cui facciamo il male senza saperlo, senza volerlo, in cui, soprattutto, non facciamo mai il bene, neppure a chi amiamo. Solo da spazio e tempo astratti, invero, ci può raggiungere una nota di consolazione. E come non è destinata a compiersi la vita, come non può comporsi in disegno razionale il mondo, così non può neppure il romanzo, che resterà con trama incompiuta, con vistose incongruenze là dove i diversi capitoli, scritti e pubblicati in momenti diversi, sono stati accostati, come in un assemblaggio di frammenti.
Ma perché, allora, il grande prefatore della prima edizione del romanzo nella sua veste attuale, Gianfranco Contini, insiste sul fondamentale ottimismo di Gadda, di cui fu amico per decenni? I primi capitoli sembrano scorrere sulla falsariga dei Promessi Sposi: dall’apertura, dove si presenta, mascherato nell’onomastica da paese sudamericano, lo stesso ambiente geografico; alla lunga camminata, verso la casa dell’hidalgo, da parte del dottore, quasi il corrispettivo contemporaneo di don Abbondio. Così, nel corso della narrazione, tra gli oggetti che scatenano l’ira funesta di Gonzalo troviamo le campane, più precisamente, sfacciatamente fragorosi, i sistemi campanari tridentini, mentre frequente è anche l’evocazione grottesca di San Carlo, dopo la cui festa soltanto, e di colpo, si fanno morbide e commestibili le altrimenti marmoree pere butirro. Il mondo manzoniano, potremmo dire, e quello pariniano, anche, con frequenti, scoperte citazioni, nel loro deplorevole sovrapporsi allo scenario della vita di Gonzalo, nonché dello stesso autore, non possono che essere rabbiosamente smascherati come ridicola mistificazione idillica, come “scrittura di bugie”, che solo può essere deturpata dalla più feroce satira e poi strappata. Eppure, stando a L’ingegnere in blu di Alberto Arbasino, che a sua volta gli fu intimo assai a lungo, Gadda sul letto di morte si faceva leggere a voce alta il romanzo manzoniano. L’ultima lettura toccò al mattino successivo alla notte dell’Innominato. E l’ingegnere avrebbe proferito: “E adesso, le campane.”
Contini si sofferma soprattutto sullo straordinario marchingegno della lingua, che offre al critico l’occasione per una breve esplorazione dei precedenti maccheronici, ed espressionistici in genere, nella letteratura italiana, padana in particolare, a partire dal Folengo fino al Dossi. Una lingua inventata, un impasto inedito ed inimitabile di forestierismi, latinismi, importazioni dialettali (le “egutturazioni” della “Neokeltiké”!), figure etimologiche, termini tecnico-scientifici. Vediamone un esempio in un passo in cui si descrive l’eloquio di due paesani intenti a raccontare un fatterello:
“Il referto era un epos bituminoso, tutto ruggiti e fratture. Gutturaloide alla sua scaturigine, la miseria dell’espressione finiva ogniqualvolta per incanalarsi in un ritmo stento, monosillabico, ossitono. Interiezioni continue e levate di spalle continue, a rincalzo del dramma, con ululati, dai cupi assortimenti delle ü celtiche e gargarizzati cachinni: e poi dinieghi e sorrisi con battute felici. Il contegno del narratore e della narratrice si inserivano nel dramma, come il coro in Euripide, ma qui pavoneggiandosi di penne critiche e secondo una burbanzetta paesana, probabilmente sindacata, dimentica talora, sì, del barbiere e ignara d’ogni borotalco, ma regolarmente esalante urea, lipidi, valerianati, bornili e derivati dell’acido caprilico e dell’acido iso-butirrico.”
Proprio nell’invenzione linguistica, nel gusto, si direbbe quasi fisico, della ricerca lessicale, come, sul fronte del rappresentato, del particolare terragno e, soprattutto, nello sbocco umoristico di tale lavorio, Contini individua l’ottimismo cui si è accennato. Lasciamo la parola al critico:
“Gadda troverà la salvezza che gli è propria, quel tanto di purgatio animi che gli compete, in altro che nelle catarsi della pura teoresi, nella contemplazione esaltante dei veri. Per conto suo, lo scatto d’un felice automatismo lo sottrae alla spira dei rimorsi e della disperazione, rettificandola abruptamente in un’umoristica icasticità di rappresentazione, nella quale, per giunta non si percepisce neppure più lo strido della caricatura amara, ma il riso, appoggiato com’è a un’intensa fiducia nel reale, appare esaurientemente liberatorio. “ “Così si verifica il paradosso (…)e dell’arte macaronica esercitata su una materia, sia detto per più rapida intelligenza, freudiana; e della sindrome dolorosa che si cura in ricette classiche di comicità erudito-plebea, d’un ottimismo eventualmente preterintenzionale, ma sicuramente collaudato.”
Tra gli esempi forse più calzanti, oltre che famosi, a documento delle osservazioni continiane, la sequenza dedicata alle ville, sulle quali (l’osservazione è sempre di Contini) “l’ultimo celebratore delle villeggiature lombarde spande la piena delle sue beffe “:
“di ville! di villule!, di villoni ripieni, di villette isolate, di ville doppie, di case villerecce, di ville rustiche, di rustici delle ville, gli architetti pastrufaziani avevano ingioiellato, poco a poco un po’ tutti, i vaghissimi e placidi colli delle pendici preandine, che, manco a dirlo, ’digradano dolcemente’: alle miti bacinelle dei loro laghi.”
Architetti pastrufaziani, cioè milanesi: e così tocchiamo di passata un altro aspetto del macaronico gaddiano, la toponomastica. La quale, nel nome scelto per mascherare Milano, Pastrufazio, riassume uno dei nodi del tormento di Gonzalo-Carlo Enrico: l’ira per quello che possiamo chiamare l’efficientismo inefficiente, l’intenso, benintenzionato darsi da fare che non mette capo a nulla di buono.
Ma, per concludere questi cenni che non pretendono di essere altro che un invito alla rilettura, torniamo all’intensa fiducia nel reale che Contini accredita a Gadda, come fonte di ciò che lo scrittore ha di più suo, ovvero l’invenzione linguistica, ma anche come limite, che lo trattiene al di qua della ‘contemplazione dei veri’, approdo di un Dante o di Proust.
Possiamo forse dire che in Gonzalo-Gadda incontriamo uno di noi. La ‘cognizione del dolore’ lo investe esistenzialmente (anche nevroticamente, ma in fondo non solo), ma non sbocca nella negazione teoretica, mentre la realtà, naturale ed umana, sempre pronta a sconciarsi indecentemente, è tuttavia sempre lì, nella sua rocciosa e struggente evidenza, lasciando anche balenare, a tratti, un vapore di immagine vera, redenta.
Bastevole, almeno, a renderci insopportabile la degradazione, a farci strappare con rabbia la “scrittura di bugie”, pur se sia indisponibile una scrittura vera. A colmarci di nostalgia.
A cura di:
Giuliana Zanello è nata a Milano nel 1957. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha insegnato al liceo classico di Busto Arsizio. Collabora occasionalmente con IlSussidiario.net