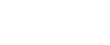MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
IL QUINTO STATO - Ferdinando Camon - a cura di G. Zanello
Il quinto stato
AUTORE: Ferdinando Camon
EDIZIONI: Garzanti, 1970
Difficile trovare in libreria Il quinto stato di Ferdinando Camon, difficile anche trovarlo on line in forma cartacea. Quand’anche non si fosse appassionati del nuovo mezzo di lettura, vale però la pena di fare uno strappo alla regola e di procurarselo almeno in formato e-book, nell’edizione Garzanti del 1970, con prefazione di Pasolini; la ristampa è accompagnata da una postfazione di Gianfranco Bettin, da una Storia del libro dello stesso Camon e da una breve ma significativa antologia della critica.
‘Il mio è un grande paese, ma le case son poche e fuori strada e non ci conosciamo l’un l’altro, anzi i pescatori che abitano a Sud, dove il fiume senz’argini dilaga sui campi e forma un mare in anticipo, quelli nessuno sapeva che esistessero, perché non si erano mai mostrati al sole e io li ho scoperti in una delle mie ricognizioni, spingendomi per vie diverse dal solito. (…) Questi Cojani non sono gente civile, perché fin dal tempo del diluvio abitavano in mezzo al Deserto, che è la campagna più sperduta da Cristo, senza strade(…). Qui i figli dei Cojani non vedevano mai anima viva se non quando si apre la caccia(…) Allora per i figli dei Cojani cominciava la grande stagione in cui quasi ogni settimana capitava di vedere la figura umana magari di lontano.’
Questo paese, che non è nemmeno un paese, si trova nella bassa pianura veneta, nelle terre che erano state di Venezia, la signora del mare colma di disprezzo per i suoi sudditi di terra, per la razza cieca che nasce e muore tra quattro zolle, quella che trova voce per la prima volta nelle commedie del Ruzzante.
In questo paese che non è nemmeno un paese, in pratica una strada e un’osteria e intorno, sparse a grandi distanze l’una dall’altra, informi, fungose e decrepite tanto da distinguersi a fatica dalla campagna in cui sono infossate, case rurali; tra campi e acquitrini e una chiesa che sorge di là dal fiume, e i contadini per andarci devono farsi forza e lasciare i soli luoghi in cui si sentono davvero sicuri; in queste nebbie, tra piante di cui Camon ci descrive praticamente solo le malattie, vive un’umanità grama e deforme, superstiziosa e folle, ignorante e malata, affamata e sfinita dalla fatica. Un’umanità che ha perso, e ha perso perché figlia di padri che hanno perso.
Quelli che hanno perso sono una razza, una razza diversa. La verità sempre sospettata illumina come un lampo la mente del ragazzo protagonista il giorno in cui va all’ospedale a trovare il nipotino appena nato:
‘ …i vetri della finestra riflettevano le immagini dei contadini, proiettandole in gruppo in mezzo al gruppo di testoline dei neonati, e le espressioni sanguigne e porcine dei padri si sovrapponevano come specchiati sembianti ai grugni ottusi e maligni dei figli, sicché mi parve per un attimo come se la vita fosse già decisa da sempre e condizionata dall’aver quella faccia e quindi quel destino (…). E guardando più lontano i figlietti degli operai, meno congestionati e più rosei, coi ditini inquieti e delicati e gli occhietti mobili sotto le palpebre chiuse, mi rendevo conto dolorosamente che prima di vedere sbriciolarsi crosta a crosta la maschera fabbricatagli da tanti millenni il contadino dovrà grattarsela per altrettanti millenni, e chissà mai se potrà farcela o se non è meglio rinunciare e contentarsi di esistere, come di fatto fa.’
Ogni confronto con il mondo esterno non fa che confermare e spingere più a fondo nell’animo l’antica umiliazione: ‘ la mia campagna non aveva niente da insegnare alla sua città, anzi forse aveva tutto da imparare, e tutto ciò che noi contadini sappiamo dobbiamo in fretta e furia dimenticarlo se vogliamo diventare uomini, perché è proprio quello che sappiamo che ci rende simili alle bestie.’
Ecco, si potrebbe dire meglio di così? Si potrebbe dare sintesi più precisa della rapidità del crollo di un mondo che pareva eterno, svanito in pochi anni a partire dal 1960, travolto dall’elettricità e dalla televisione ma soprattutto dalla furia determinata con cui i suoi membri lottarono per uscirne? Si potrebbe spiegare meglio, la cura ansiosa con cui i materani provenienti dai sassi, ad esempio, hanno per decenni nascosto le loro ignominiose origini, prima che l’antica vergogna diventasse attrazione turistica?
Il libro esce nel ’70, cioè tardi: la fine della civiltà contadina era argomento vecchio, la letteratura si andava concentrando sulla società industriale e sulle sue ferite. Poco prima del Quinto stato era già uscito anche Libera nos a Malo di Meneghello, che quello stesso mondo poeticamente immortalava. E allora? Quali le ragioni di questo libro e degli altri due che seguirono a formare il Ciclo degli ultimi, La vita eterna e Un altare per la madre?
Camon afferma di avere voluto fermare sulla pagina, di quel mondo, il lungo silenzio e il breve grido.
Il silenzio lungo, immemorabile, di millenni tutti uguali, di generazioni su generazioni di gente senza nome: uguali fatiche, uguali dolori, uguale fame, uguale malattia, uguali soprusi. Un silenzio nel quale, tuttavia, al mondo si era pur data una forma, la forma di un mondo umano, che come tale si rivendica, nel libro, in particolare in rapporto ai tedeschi invasori e alla loro crudeltà bestiale.
Il grido breve dell’agonia, nel quale un mondo sfaldato, nell’atto di scomparire, parla per la prima volta per bocca di uno dei suoi.
Uno dei suoi. E questa è la differenza profonda tra la voce di Camon e quella di Pasolini, o anche di Meneghello. Camon è partito da lì, dal cerchio più lontano, per usare la sua stessa metafora dantesca.
Ha tradito, in un certo senso, per poi tornare e tradire un’altra volta. Il secondo tradimento è quello della scrittura che strappa quel mondo misero e pudico al silenzio con cui ha sempre coperto la sua vergogna, che gli restituisce la vita ma insieme lo viola.
Ultimata questa sua prima fatica letteraria, Camon la invia a Garzanti che la fa leggere a Pasolini, il quale non solo ne approva la pubblicazione ma ne scrive anche la prefazione, generosa ma non priva di riserve, che Camon medita e anni dopo rigetta. Pasolini gli aveva in un certo senso rimproverato il tradimento di una descrizione priva di speranza, l’implicita preferenza accordata ad un ‘meglio’ piccolo borghese già votato al degrado consumistico. ‘Questa, per Pasolini era la salvezza. La campagna doveva restare un’oasi fuori-storia, dove la borghesia potesse rifugiarsi, per salvarsi dall’alienazione. (…) Ma avrei fatto un’opera arcadica o elegiaca, il rimpianto di una condizione umana che non ha niente e non vuole niente. Pasolini non era nato e non aveva vissuto tra i contadini. Io purtroppo sì. E sapevo che lo sbocco dentro la civiltà borghese era il sogno inconscio e disperato di tutte le civiltà contadine della Terra’. Niente ‘fortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas’: forse Pasolini poteva dire le stesse cose di Virgilio, un contadino no, perché lì si stava male, male da morire.
Il romanzo ci porta dentro quel mondo attraverso gli occhi e la mente di un suo abitante bambino, raccontato dall’adulto che diventerà. La civiltà contadina viene scoperta e imparata con la terribile maturità di quei bambini a cui nulla veniva risparmiato, in una sorta di flusso di coscienza che ripete l’astoricità e la trasfigurazione mitica del racconto degli adulti, raggrumandosi e disperdendosi in una stratificazione complessa di passato collettivo e presente individuale. Dialetto e italiano sono accostati e intrecciati non come lingue diverse per indicare cose uguali, ma come lingue diverse che indicano cose diverse, pertinenti a mondi diversi. In realtà, se ciò vale spesso per la lingua comune, non sembra valere per i prelievi letterari, esibiti e insieme inseriti con naturalezza nei contesti anche più crudi, quasi a gettare in mezzo alla travagliata quotidianità del bambino dei campi l’identità colta che avrà da adulto. E questa può in effetti essere una loro funzione, far sentire la voce di chi è fuori dal mondo narrato perché è risalito dall’abisso, e proprio per questo può strapparlo al suo silenzio, finalmente disponendo delle parole che quel mondo da sé non ha generato; ciò d’altra parte introduce inevitabilmente una distanza, insieme straniante e ironica, che è la realizzazione stilistica dello strappo, col suo dolore e col suo irritato fastidio. Altre volte, tuttavia, la letteratura (Dante soprattutto), non pare venire da fuori, a proiettare la sua luce rischiosa su quel mondo infero, ma anche scaturire da dentro, esserne illuminata o riportata alle sorgenti, là dove più vivide nascono le immagini perché i corpi gridano più forte il loro bisogno e le anime il loro desiderio.
A cura di:
Giuliana Zanello è nata a Milano nel 1957. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore e insegna al liceo classico di Busto Arsizio. Collabora occasionalmente con IlSussidiario.net