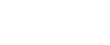Letteratura
PIN lo spazzacamino
di Alessandro Grittini
Editore: itaca 2025 - €10,00
Pagine: 142
Target: da 11 anni
A tre anni dal fortunato esordio di “Costellazione Kurt”, Alessandro Grittini torna nelle librerie con “Pin lo spazzacamino”, un bel romanzo per ragazzi che arricchisce la collana Icaro della casa editrice bolognese.
La storia
Il protagonista è Pin, un ragazzino di dieci anni che parte da un paesino della Val Vigezzo per fare lo spazzacamino nelle città. Ambientato negli anni d’inizio 1900, il romanzo racconta della grande povertà diffusa anche nel Nord Italia e nelle vallate alpine in particolare: “Certo, lassù in paese trovare lavoro era impresa impossibile. La terra era fredda e arida e non dava molti frutti.”
I giovani erano costretti a emigrare in città o all’estero e inventarsi un mestiere: il minatore, lo stagnaro, l’arrotino, l’ombrellaio e - il lavoro destinato ai bambini - lo spazzacamino.
Le vicende di Pin si svolgono in un breve arco di tempo, dall’autunno inoltrato, quando dopo la morte del padre parte dal paesino, sino ai giorni di Pasqua, allorché, terminata la stagione di pulizia dei camini, fa ritorno.
I suoi compagni di viaggio sono Titta del bosco, un uomo burbero ma buono, che ogni anno porta con sé alcuni bambini a fare gli spazzacamini nelle varie città, Beppe, un ragazzino di qualche anno più grande, e suo fratellino Tarcisio; questi ultimi due, dopo poco tempo, ritorneranno a casa a causa di una brutta polmonite contratta dal più piccolo.
Gli spostamenti avvengono con un carretto trainato dall’asino Berto, prima lungo la Val Vigezzo, poi imbarcati su un traghetto sul Lago Maggiore fino ad Arona, successivamente nelle città di Oleggio, Novara, Vigevano, Pavia, ancora Novara e, da ultimo, Torino.
Durante la narrazione di questi mesi Pin compie anche altri tipi di viaggio: quello di imparare un mestiere e sopportare la fatica, di accettare le privazioni e la lontananza dalla propria famiglia, di incontrare nuove persone e situazioni inedite, di imparare a fidarsi e, nello stesso tempo, di non smettere di dare retta a ciò che sente nel suo cuore. Compie, cioè, un percorso di crescita dal punto di vista dei valori e della volontà personale, elementi fondamentali nel fronteggiare la realtà e le sue inevitabili contraddizioni.
Le tematiche
Il realismo storico è un tratto caratteristico nella narrazione di Alessandro Grittini e anche in questo lavoro esso emerge in modo equilibrato ed efficace. La passione di storico che ha sempre accompagnato le sue indagini gli ha permesso di tenere vive e riconsegnarci realtà del passato completamente ignorate e dimenticate. Nella “Nota dell’autore” posta al termine del libro si legge: “Il racconto è ispirato alla tragica epopea dei piccoli spazzacamini delle valli piemontesi, valdostane e ticinesi; […] è uno dei più gravi casi di sfruttamento minorile che il nostro Paese ricordi, […] legata alla particolare miseria di queste terre”.
Questo romanzo ha la forza di documentare la dura realtà di quegli anni e, nello stesso tempo, anche il pregio di rappresentarla in modo comprensibile per i giovanissimi attraverso lo sguardo e l’umanità di Pin, un ragazzino che comincia a prendere piena consapevolezza di quel mondo. Di fronte alle difficoltà il piccolo spazzacamino mette in gioco le convinzioni e i valori con cui è stato “tirato su”, cresce (come molti bambini in quelle situazioni) velocemente e riesce ad essere un protagonista credibile, nel quale immedesimarsi con facilità durante la lettura.
Un altro aspetto che compare nel racconto è una sorta di Divina Provvidenza di manzoniana memoria: un bene presente sottotraccia che, attraverso una serie di incontri, emerge e aiuta il nostro protagonista a superare le situazioni negative o problematiche. Si tratta dell’incontro a Pavia e poi a Torino con Michele, un ventenne romagnolo che fa lo stagnino e suona la fisarmonica, col quale nasce una bella amicizia. Della signora Amalia e di suo marito avvocato e senatore, una ricca famiglia torinese con villa e risaie a Novara, con la quale vengono in contatto grazie al lavoro nei camini. Delle dame di beneficenza dell’Opera Pia di Pavia, nella quale Pin e gli altri bambini spazzacamini trovano accoglienza nel giorno di Natale. Del salesiano don Aristide, che gestisce l’opera di carità di Valdocco a Torino, fondata da San Giovanni Bosco per l’accoglienza e l’istruzione dei giovani e dei bambini poveri. Attraverso l’aiuto di queste persone Pin riesce a superare una serie di ostacoli e a favorire un epilogo positivo nella storia della sua famiglia.
La struttura e lo stile narrativo
Il romanzo è suddiviso in diciotto brevi capitoli, ciascuno dei quali è presentato da un titolo che introduce a ciò che sta per accadere e contemporaneamente aiuta a tenere in mano il filo della storia. Il Prologo – due paginette di apertura - mette in scena uno spazzacamino in azione, comunica la tensione e la concitazione di quei minuti, dichiara la “materia” trattata nel romanzo e anticipa un fatto che solo a metà libro verrà completamente rivelato.
Lo svolgimento temporale è costruito su due grandi fasi: i primi tre mesi e mezzo, nel corso dei quali avvengono tutti i fatti più importanti legati al piccolo spazzacamino, e gli ultimi due, sintetizzati nel capitolo conclusivo nel quale si racconta come e dove sono andati a finire tutti i personaggi della storia.
Grittini utilizza uno stile narrativo adatto ai ragazzi, con periodi brevi nelle scene “in presa diretta”, come i momenti di azione con una certa tensione o i dialoghi che portano a cambiamenti e snodi importanti; periodi complessi, invece, laddove la narrazione si fa più descrittiva o riflessiva. Rispetto al lessico l’autore fa ampio uso del “vocabolario esteso” (scelta che favorisce nei ragazzi-lettori una crescita linguistica), e inserisce qua e là termini dialettali legati perlopiù alle attività dello spazzacamino, un modo anche questo per tenere viva la memoria storica di quel mondo.
Spunti e agganci con la didattica
Il romanzo si presta anche per avviare attività di riflessione linguistica a tutto campo: dalla comprensione del testo alla ideazione di riassunti, dal soffermarsi sugli incipit dei singoli capitoli e sul loro finale (per coglierne cambio di direzione, sospensione, efficacia … e “rubare idee” per la produzione scritta), dalla presa in esame dei vocaboli in dialetto ai termini dialettali in uso nella lingua italiana, dalla ricerca della etimologia di una parola alla scoperta e uso delle espressioni idiomatiche. Da ultimo, ma solo in terza media, PIN lo spazzacamino può essere utile per una documentazione delle condizioni di vita nella storia del Nord Italia di inizio Novecento, oltre che per un confronto con le altre realtà sociali ed economiche raccontate nel nostro Verismo.
A cura di:
SERGIO FANNI. Laureato all’Università degli Studi di Milano, ha insegnato Lettere nella secondaria di I grado di Santo Stefano Ticino (MI) dal 1983 al 2005 e, successivamente, nell’Istituto “San Girolamo Emiliani” dei P.P. Somaschi di Corbetta (MI). Dal settembre 2020 è felicemente in pensione e prosegue il suo impegno educativo/didattico come volontario presso l’istituto di Corbetta.